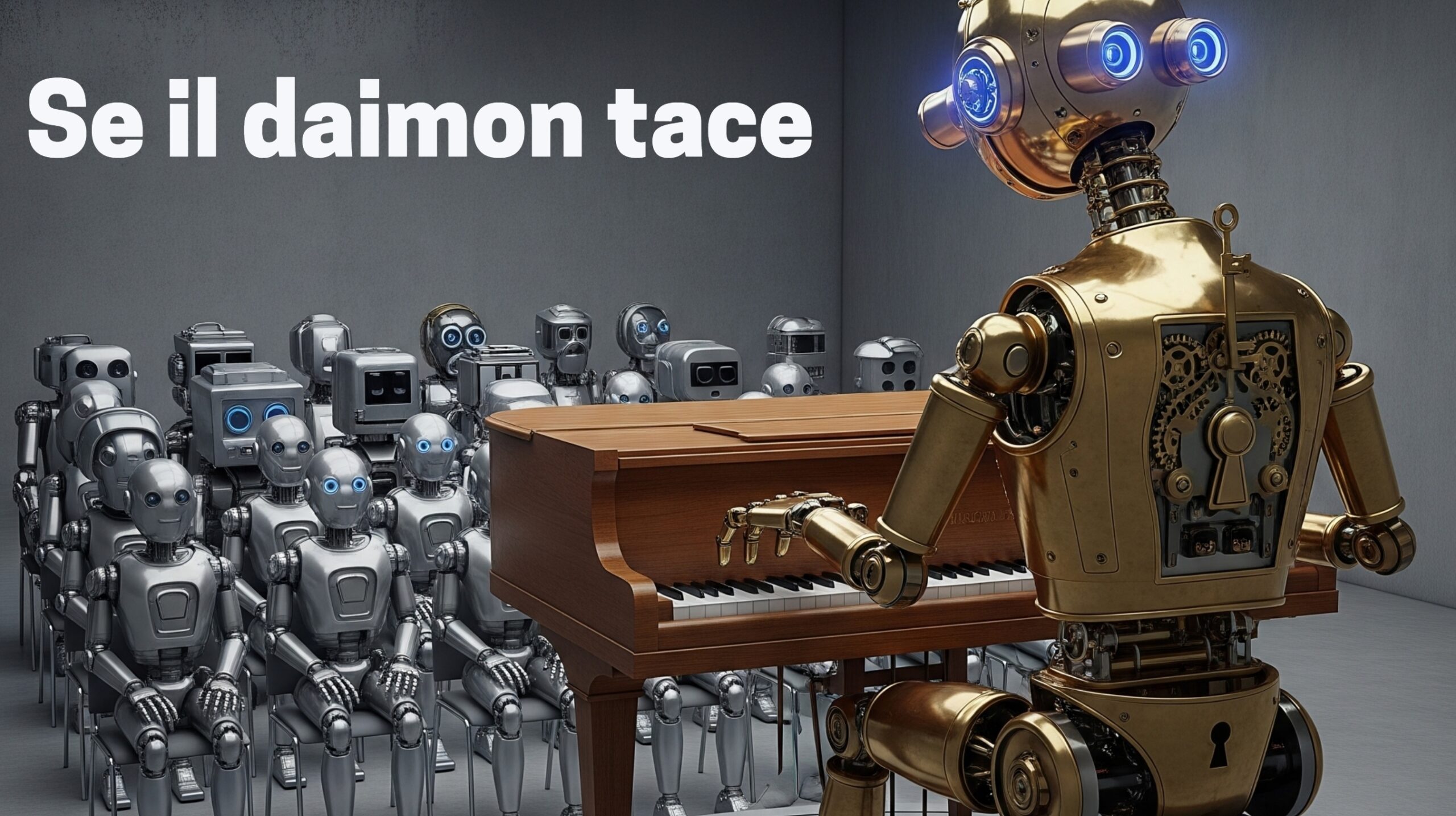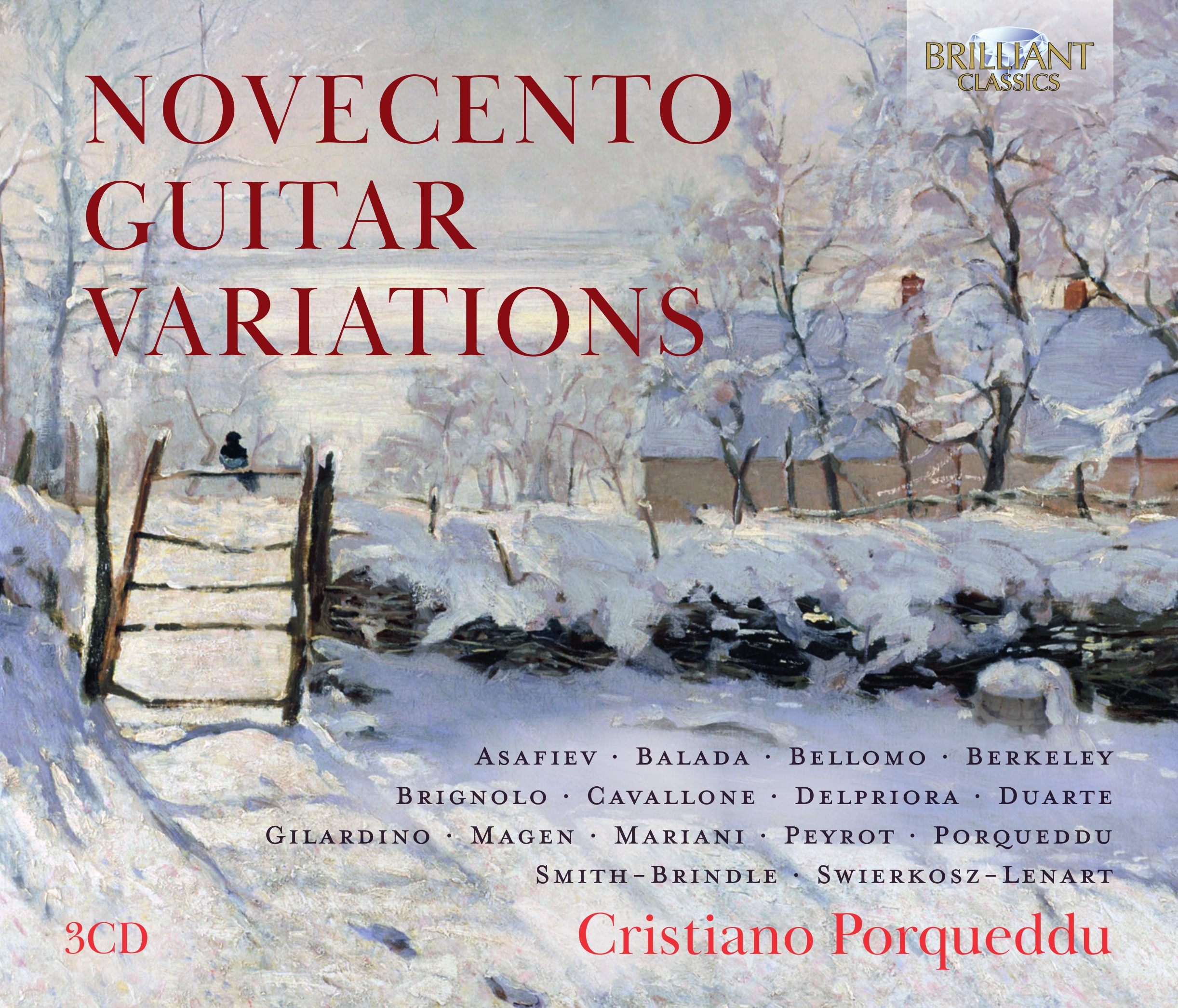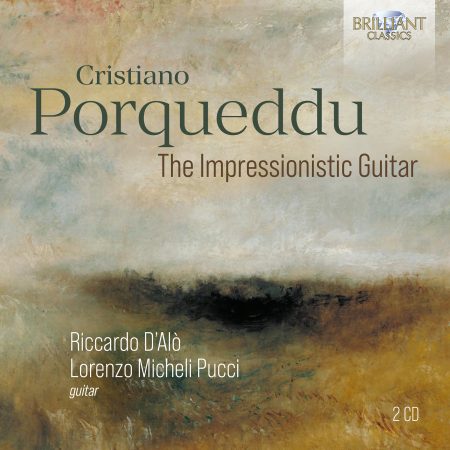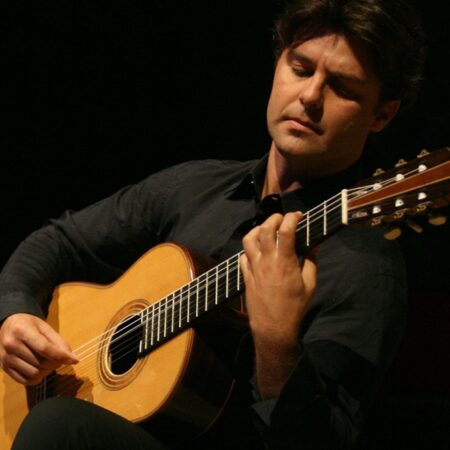I topoi del romanzo barocco sono la sensualità e la rappresentazione del corpo, soprattutto femminile, allo scopo di rappresentarne la bellezza; l’esagerazione nelle metafore con la creazione di immagini vivide e che mirano a sorprendere chi legge; i mondi fantastici con richiami al mondo della fiaba che spesso traggono ispirazione dai poemi cavallereschi e ancora, la morte, la ricerca dell’identità. Nell’ambito dell’arte figurativa troviamo il movimento, energia e vitalità; il trionfo, scene di apoteosi e gloriose e quindi il conseguente senso di stupore e meraviglia; il senso della morte e la brevità dell’esistenza i cosiddetti chiaroscuro, i contrasti di luce per creare effetti drammatici ed estremizzare il ruolo di una parte di un’opera; l’allegoria, il mito, il simbolismo.
Dalla letteratura all’architettura, dalla pittura alla scultura: forma, sì. Tecnica, sì. Ma dramma, fantastico, amore, carne, apoteosi, avventura, amore, morte. L’obiettivo non è né la forma né la tecnica.
Ed è sufficiente guardare e leggere ciò che è giunto, di quell’epoca, ai giorni nostri.
Adesso, siccome è il mio ambito di competenza, spostandomi nel campo della musica mi è davvero difficile con un siffatto preambolo non rimanere deluso nell’ascoltare una preoccupante percentuale di interpreti che trasforma le pagine degli autori di quel periodo, indipendentemente dallo strumento, in esecuzioni che – per usare un termine matematico – tendono al file midi, ovvero allo zero: l’assenza di indicazioni dinamiche, per ragioni tutt’altro che artistiche!, porta quasi sempre ad esecuzioni asettiche, da impiegato della musica, diceva un amico; rari gli slanci espressivi e nel migliore dei casi, molto è ridotto ad una esasperazione di dinamiche “a terrazza”. Certe esecuzioni dopo pochi minuti divengono insopportabili, un blaterare continuo interrotto dalle pause della fine dei periodi o più spesso dei movimenti movimenti che ricordano fin troppo il gesto di prendere aria a bocca aperta quando si è stati sott’acqua per troppo tempo.
Poi ascolto le interpretazioni di Glenn Gould.
E mi viene da pensare che sostanzialmente, come accade nella letteratura, nella pittura e nell’architettura il dovere di chi legge diventa responsabilità. La capacità di introdurre la propria personalità nell’esecuzione arricchendo la visione del compositore è un’operazione che richiede ben più della conoscenza del ruolo del soggetto e del controsoggetto, di come si sviluppa il secondo tema o di come modula da qua a là. Ancora una volta è chiaro che la conoscenza tecnica serve non serve se non mira a realizzare qualcosa inciso sull’elica del DNA.
Se il daimon tace, il master e il dottorato e la menzione e la lode e la tournée e la discografia diventano oppiacei.